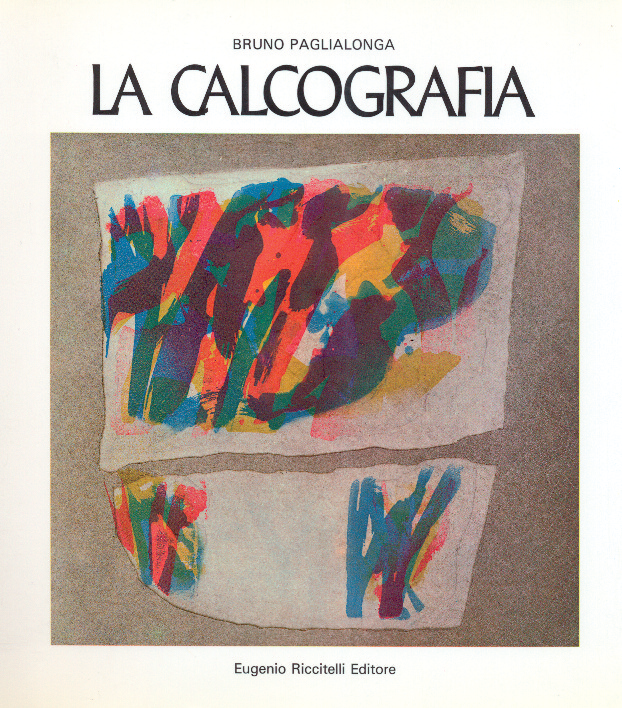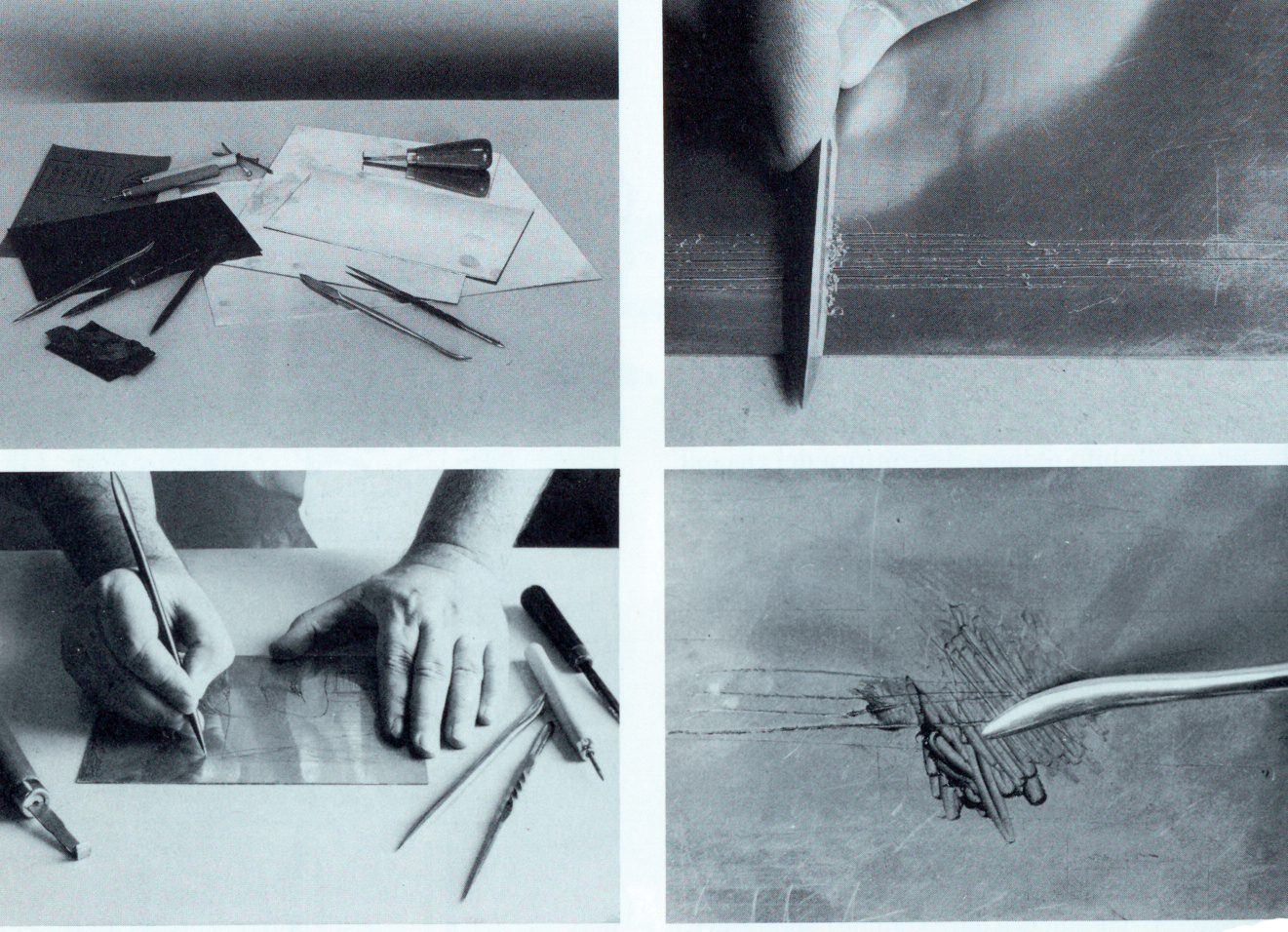7 Dicembre 1987
La prima popolazione che abitò Vasto fù costituita, secondo la leggenda, da tribù provenienti dalla Dalmazia. Il primo nome, Histon, venne dato a Vasto da Diomede, il quale arrivò sul posto alla guida degli Illiri; Histon, infatti, ricordava il monte Histone di Corfù. Verso il V secolo a.C. il sito fù occupato dai Frentani che potenziarono il primitivo approdo di Punta Penna. Le tante iscrizioni osche e i recenti rinvenimenti di anfore nel golfo di Vasto, testimoniano l’esistenza di traffici marittimi, nonchè la grande importanza della città nel territorio frentano. Dopo la guerra sociale (91-88 a.C.) Histon divenne Histonium e fù elevata alla dignità di Municipio Romano e durante l’età imperiale acquisì potenza e prestigio. In epoca post-imperiale la città non fù risparmiata dalle invasioni barbariche alle quali fece seguito un periodo oscuro nel quale si perse addirittura il suo nome. Un conquistatore franco, Aimone, eresse, sulle rovine dell’antica Histonium, un borgo fortificato, da lui chiamato Guast d’Aymone. Dopo il periodo angioino, che lasciò delle tracce profonde nel lessico, Vasto fù assegnata ai D’Avalos, di origine spagnola, che vi trasferirono il fasto della corte iberica e innalzarono uno splendido palazzo: il Palazzo D’Avalos; la città, per la sua bellezza, fù chiamata “Atene degli Abruzzi” Il Palazzo D’Avalos fù distrutto dai Turchi nel ‘500, ma subito ricostruito in forme rinascimentali; fù anche dimora di Vittoria Colonna. Al suo interno oggi si trovano il Museo Archeologico e la Pinacoteca. La città alta conserva molte testimonianze del suo passato; resti di ville Augustee e tracce di insediamenti medievali (…)
dal sito della Città di Vasto (www.comune.vasto.ch.i)