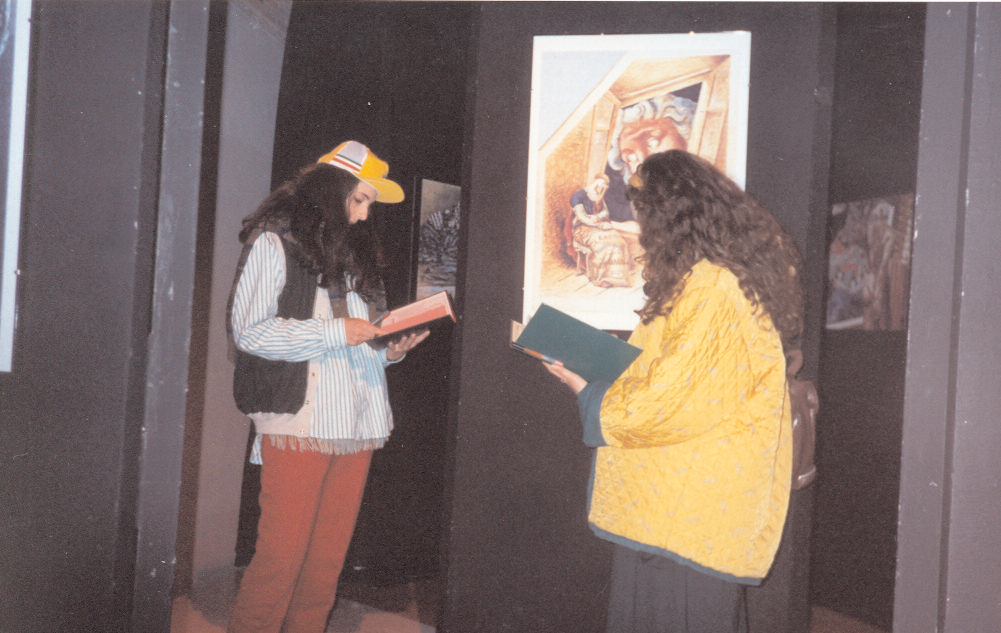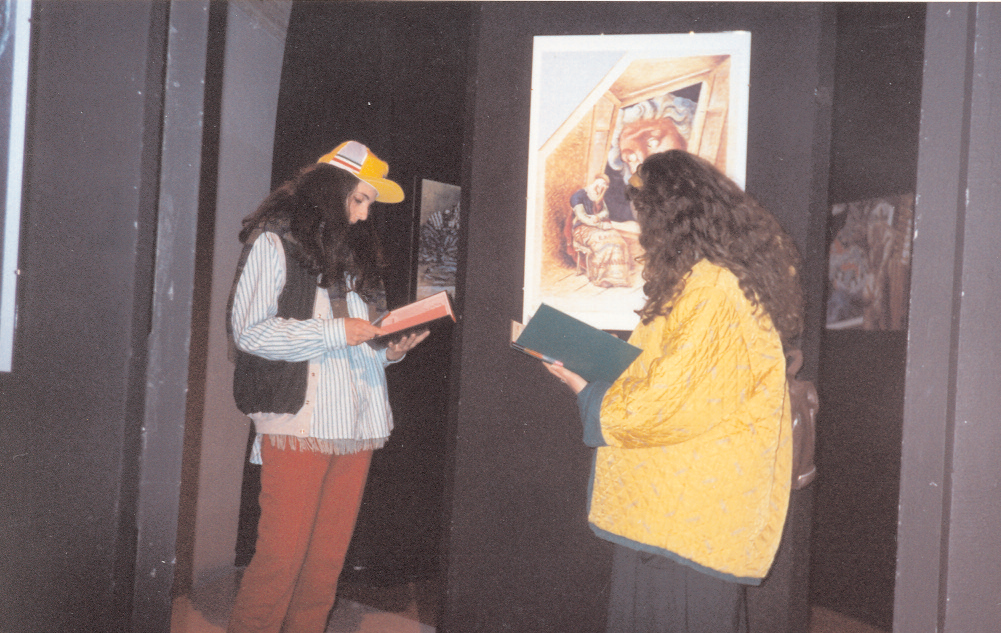25 - 26 Febbraio 1994
Una venatura orfica percorre la letteratura italiana del Novecento, ma l’orfismo presunto si scopre velleitario, visto da vicino, pur se fecondo e suggestivo. Troviamo però autori e opere non “accreditati ufficialmente” che nascondono una nervatura orfica più genuina quanto meno conclamata. L’orfico vero si riconosce per la sua reticenza a dichiararsi tale, per il sorriso di fronte alla tragicità dei misteri ultimi. Tale è la natura di Alberto Savinio e del suo “Dico a te, Clio”. Narrare d’un viaggio compiuto appena fuor della porta di casa, come in questo libro, comporta il rischio dell’autocompiacimento. L’autore ha una vena asciutta e paradossale che gl’impedisce l’autobiografismo, e coltiva l’arte dei pittori antichi, i quali « (…) cercavano (…) di rendere duraturi i colori (…) volevano che la pittura fosse, prima che rappresentazione, cosa mirabile in sé, solida, brillante come un gioiello». Muovendosi fra i monti e le spiagge d’Abruzzo a bordo d’una Topolino (siamo nel ’39), errando fra i sepolcreti dell’antica Etruria, Savinio rifiuta le mascherature mitologiche care a tanti scrittori suoi contemporanei. Certo, incontrerà i Dioscuri camuffati da giovani sportivi, si farà accompagnare dal molesto guardiano degl’inferi Caronte, ma è, di suo, abbastanza padrone del mito, per poter ascoltare le voci della natura e degli astri non meno che quelle dei trapassati, e accogliere in un’ordinata compresenza le costumanze pastorali, gli arredi funerari, le corse in automobile. Attentissimo, come i Greci fra i quali è nato, «alle parole udite fortuitamente, a talune sensazioni del corpo che essi interpretavano come presagi ». Con tutto ciò che di virtuale, divinità o miraggio, possa consentire a lui (e a noi suoi lettori) di sondare le profondità dell’uomo al di là delle barriere d’epoca e civiltà senza che c’inganni la loro superficiale limpidezza. Discepolo eretico di Nietzsche e di Freud, Savinio prende a pretesto il paesaggio italiano, stratificato di monumenti, popoli e civiltà, per enucleare poche costanti eterne. Il viaggio, di per sé tema squisitamente mitico, è dapprima nostos, ritorno dell’esule, poi catabasi nel mondo sotterraneo dei trapassati, alla ricerca d’un nodo archetipico irrisolto. Dove più il nodo è intricato, nella seconda parte del libro che ripercorre le orme degli Etruschi, più Savinio, sul loro esempio, si fa reticente. Se quelli incutevano timore «per la forza dei loro segreti: per quello che si ostinavano a non dire», lo scrittore moderno ha come unico baluardo il linguaggio. Tersissimo, quello di Savinio: le sue scelte lessicali, i suoi ritmi non sono pedestri cartelli indicatori di una geografia dell’anima; la memoria di viaggio non è affatto sentimentale, semmai un’accettazione della distanza, della misura, dell’ineluttabile, di se stesso come presenza fra tutte le presenze, storiche e naturali. Nulla resta, fra tanta esattezza figurale, delle urgenze e confusioni futuriste; la svolta necessaria dal progressismo all’atemporalità si è consumata. Fra i doni di questo libro, la composizione non è certo tra i minori: lo scrittore sembra gareggiare col pittore, nel ritagliare fatti e personaggi, nel collocare con sapienza prospettica palazzi, città, montagne. La circolarità, anche se non programmatica, fra le varie arti praticate dal Nostro, scioglie le formule a volte troppo concentrate della sua maliziosa misantropia. Suo fratello De Chirico, il Pictor Optimus, predicava l’assoluta preminenza, in pittura, del disegno, elemento simbolico e astratto. Più sottilmente, Savinio incetta simboli e li fa cadere sotto gli occhi del lettore con gesto svagato da prestidigitatore: «la vita migliore è quella ridotta a simboli». Simboli, cime d’iceberg dalle forme eterne dentro le quali è radicato l’uomo, esplorabili e rovesciabili come un guanto. Ogni cosa vista è il pretesto per un aforisma, ogni gesto umano, ogni paesaggio, ogni particolare minuto sarà uno scarto, un soprassalto da accogliere e ordinare dentro la misura. Un’Italia che muta e non muta, quella descritta da Savinio, classica ma minata da germi di corruzione: non la modernità è causa di rovina, ma il lezio, la rinuncia alla durezza delle tradizioni. Ci piace ricordare la polemica contro la volgarità del cemento, materiale modellabile, privo d’interiorità, a differenza della pietra, o il turbamento di fronte agli innesti cristiani sulle vestigia del paganesimo. Tutto è abbastanza vicino ma inquietante, tutto è abbastanza chiaro ma sfugge, la ragione va anatomizzata come i sentimenti. La memoria del viaggio, della natura primordiale e dei resti archeologici, si orchestra per temi vettoriali. «Il passato è avido di avventure, ma senza reciprocità». Passato e avventure, senza mediazioni; il tempo narrativo s’incolla, illusoriamente, su quello esistenziale. Anche per noi che leggiamo nel terzo millennio, questa corsa per l’Italia del 1939, questo linguaggio secco e iridescente, ci sconcertano, come se fossero nostri.