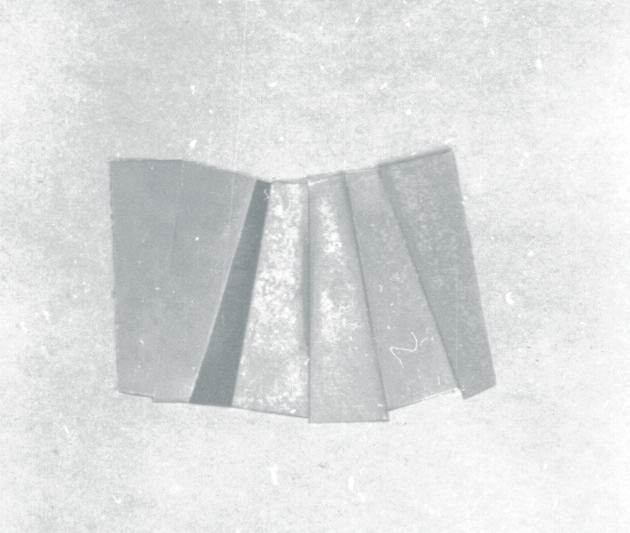14 Novembre - 14 Dicembre 1991
Giancarlo Piccirilli mette all’ordine del giorno la rivisitazione “fisica e lustrale” del mondo, della sua natura ormai compromessa e in ritirata. Piccirilli si avvale con singolarità del disegno architettonico e del design, per quelli che assai propriamente chiama “lavori”. C’è in lui, nel rapporto costante di reinvenzione della materia, la stessa ansia d’uso dell’artigiano. Lo confermano i materiali, pietra e legno, della sua pittura che sconfina, in ogni rappresentazione, nella scultura. Più che la dimensione del mito, la sua intenzione è la riproduzione, la “reversibilità” dell’ universo stesso. Un tentativo continuo di rielaborare la superficie, la pelle dei materiali naturali che adopera, sproporzionando su scale interiori gli scenari dell’ origine, della radice del mondo. La patina finta, su scala uno a uno, della pietra e delle venature del legno ricorda l’operazione culturale del rococò: quel falso manierato e volutamente abbondante che dà conto dell’impraticabilità del reale così com’è. E che si presenta per sostituirlo. Un’astuzia creativa che si misura anche con la necessità di ricostruire le venature, le pieghe, la “fessura” dell’universo, ponendo ancora una volta di fronte ai propri occhi l’idea di una “soglia” da varcare, da penetrare per scoprire. Il risultato finale che Piccirilli conquista è crudele e lucidissimo: la terra, ancorché desolata, è ormai terra di nessuno – l’umano e il suo sudore appaiono azzerati – e i tempi della vita possono ancora essere, se ricostruiti dall’amore della ricerca febbrile, solo i tempi del legno e della pietra. All’opposto di questa visione da panta rei di Piccirilli stanno invece le pitture di Stefania Fabrizi, ossessivamente fondate sulla riproposizione dei corpi come rielaborazione della figura antica. Quel che interessa alla sua ricerca è proprio la commistione tra natura e presenza umana, come se l’ombra dell’ essere vivente fosse l’unico limite possibile per definire lo spazio; a partire dai contorni dell’ombra, dai sedimenti di movimento rimasti nella rifrazione dei colori. Il corpo umano diventa dunque il centro della luce. Assai particolare è il fatto che per il suo lavoro la pittrice senta il bisogno di assumere su di sé il carico di un nuovo racconto del mondo, di scoprire e inventare una sua mitologia di eventi che sperimentino la ricomparsa della luce da assorbire e riprodurre. E’ il caso dei grandi pannelli-pellicola. Separatamente, essi compongono un’opera davvero affascinante, che rivisita un volto pompeiano riprodotto nell’incanto della sua serenità: sono i pannelli dei dieci angeli che soffiano ossessivamente sui rotoli di carta della storia ancora non srotolata. Un’opera unica in quanto a nuova figurazione simbolica. O quello delle “alte maree”, dove corpi volutamente non completati subiscono l’accadere della luce, mentre l’acqua ormai li sovrasta, a creare, invece che corpi offesi nel terrore degli elementi, soltanto puri “campi di luce”. E poi, invece del topos delle bagnanti, modello storico della pittura moderna, ecco “I bagnanti” che, nella singolare trama narrativa dell’autrice, propongono l’acqua in cui sono immersi a livello dello spettatore che guarda. Immersi, si direbbe, piuttosto che nei rimandi moderni o contemporanei, nel Rinascimento, nella luce “riflettente” blu-cobalto delle volte rinascimentali. Non tragga in inganno, però, l’elemento epico, o la passionalità dei volti raffigurati, diversamente intensi. Ogni intervento serve alla Fabrizi per il suo laboratorio di “macchie”; le sue figure, infatti, sono in funzione della macchia, del suo rapporto con la luce centrale emanata da un colore sotteso, nascosto “Dietro la macchia” (è il titolo di una sua tela significativa di creta e gessetti). In Pierluigi Fiore c’è la stessa ricerca del centro (equilibrio, non luce), lo stesso rapporto esclusivo con l’acqua, lo stesso riferimento al Rinascimento, ma anche al Barocco e alla sua ricchezza di linguaggi. Ma in una elaborazione condotta con mezzi e finalità poetiche contrapposte al “narrativo” di Stefania Fabrizi. Fiore presenta carte, srotola pergamene e manifesti, apre quaderni, nell’intento di comunicare “frasi” che è proprio del poeta. Le sue scritture vivono per inchiostri e colori di terra, in un rapporto vitale con la liquidità di cui sono composti. Il tentativo, pienamente riuscito, è quello della raffigurazione di un nuovo alfabeto storico, capace insieme di decodificare le componenti simboliche del mondo arcaico – le forze e le forme che insieme hanno contribuito a costruire il capitello ionico – fino a ingegnare nuovi orologi personali, clessidre, strumenti sensibili che possano misurare tutto il peso che grava sul mondo. Un lavoro che lo stesso Fiore ha definito in modo appropriato: “Il dono e il sacrificio”. E’ la ricerca di un centro del mondo scelto come territorio di fuga, ma anche di ritorno. Una pittura che traccia graffi, microsolchi come segnali del passaggio dell’umano. Una pittura-scrittura che non finisce nell’atto della sua resa sulla carta, ma continua attraverso il grado di assorbimento dell’umidità – inchiostri e terre – sul foglio, perseguendo il suo gioco fino all’essenza, che diventa nient’altro che liquido. Tornano gli angeli in Laura Barbarini, ma invece che figure simboliche realizzate e compiute, ecco puri ammassi di luce nella rigorosa rappresentazione del loro movimento. E’ una pittura alta che rimette in gioco la stessa esistenza dei colori. La nebulosa esistenza dell’angelo è il mistero che permette all’artista di riproporre la nebulosa che ha portato alla formazionepercezione dei colori. Se umani e cose appaiono accomunati nel loro azzeramento, soltanto in evoluzione può essere restituito il movimento di vortici che arriva a comporsi in materia e vive per poco tempo, miracolosamente, nel volo e nella luce dell’innalzamento dell’angelo, nella disperazione della sua precipitazione, come Lucifero. Un movimento, spiegano le sue tele di grandi dimensioni come i suoi piccoli cartoni, che è anche movimento interiore fino all’essenziale. Sono gli angeli che “nascono” il colore. Il colore non esiste, non è mai esistito. E’ la figura fantasmatica dell’ angelo – specchio della volontà di Barbarini – che nel magma della sua nascita lo crea. E vive dall’impasto dei colori fino alla realtà materica, monocromatica, del rosso fuoco e del verde smeraldo acceso. Poi l’angelo, massa di colore, prende forma, si concretizza ed esce dalla materia pittorica e dal gesto di tracciare il segno. E’ l’evento voluto dall’autrice: un consistere e sparire, un materializzarsi e dissolversi allo stesso tempo. Di questi angeli si può dire: “Nascono o scompaiono?”, lasciando in sospeso la possibilità che le figure escano dal tempo “all’origine o alla fine”. L’emozionante ciclo dell’angelo si avvale di una tecnica originale fatta, si potrebbe dire, soltanto di materia. Per Laura Barbarini sembra infatti fondamentale ridurre al massimo l’emozione della ricerca mentre gli angeli prendono forma: i suoi ultimi lavori su carta sono non a caso tracciati in cemento “per cancellare la passione del colore e distanziarsi” e per fondare. Fino a diventare analisi fredda, “appunti” sulla macchia che era stata un angelo – e che all’improvviso torna a dissolversi nello spazio. Ed è lo spazio il protagonista della pittura di Guido Giobbi, lo spazio fisico, astronomico, e lo spazio matematico- fantastico contenuto tra vuoto e angoscia interiori. La creazione dei mondi e dei pianeti svela, dall’altra parte, la sfera dell’ occhio che scruta il buio e avvista i corpi celesti. L’ansia del siderale a malapena nasconde il disastro planetari della coscienza. La nuova sfera armillare di Giobbi parte proprio dall’avvistamento della perdita del centro e della decadenza della ragione. Vale dunque costruire, con gesso acrilico e inchiostro e su grandi pannelli di tela, una nuova fisica astronomica che materializzi le parti in cui si evolve il mondo di dentro, tra rotazioni, lame di luce, lune bisecate. Centrale, per la comprensione del surrealismo cosmico di Giobbi, è il topos della luna bisecata, con la sua luce sempre parziale. L’autore sta nella parte a metà, tra svelamento e nascondimento. I colori, anche se delicati e stravolti nel grigio intenso e nel dolcissimo rosa, retaggio d’un fuoco appena spento, sono assoluti, e riempiono lo spazio siderale come uniche presenze dell’universo. Sono colori che contengono la parzialità della luce e delle forme. E ancora gesso, acrilico, inchiostro, in un lavoro continuo di asportazione e sottrazione, con vitalismo, addirittura con graffiti da caverna se necessario, attingendo al blu, il liquido dell’universo. Sono dunque cinque giovani pittori diversi, ma ognuno è rifratto nell’altro per un gioco non voluto di sconosciuti e invisibili specchi. Come lava accesa e ferita aperta.
Tommaso Di Francesco